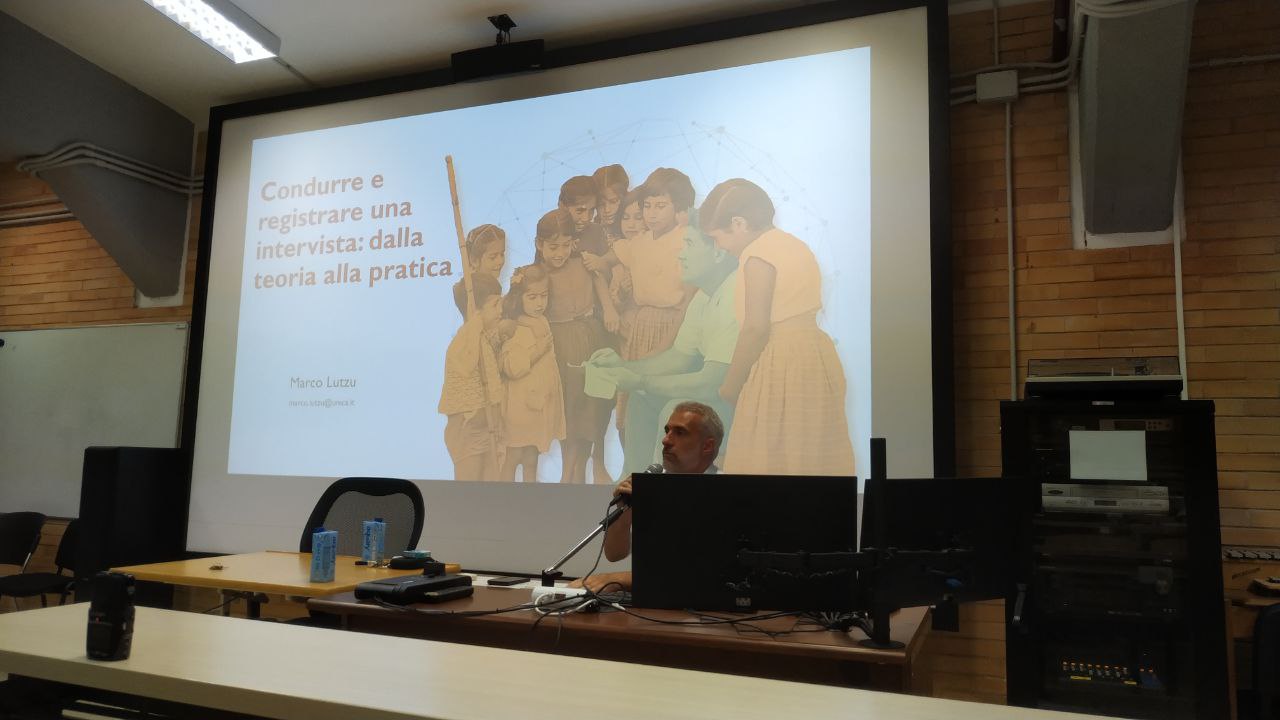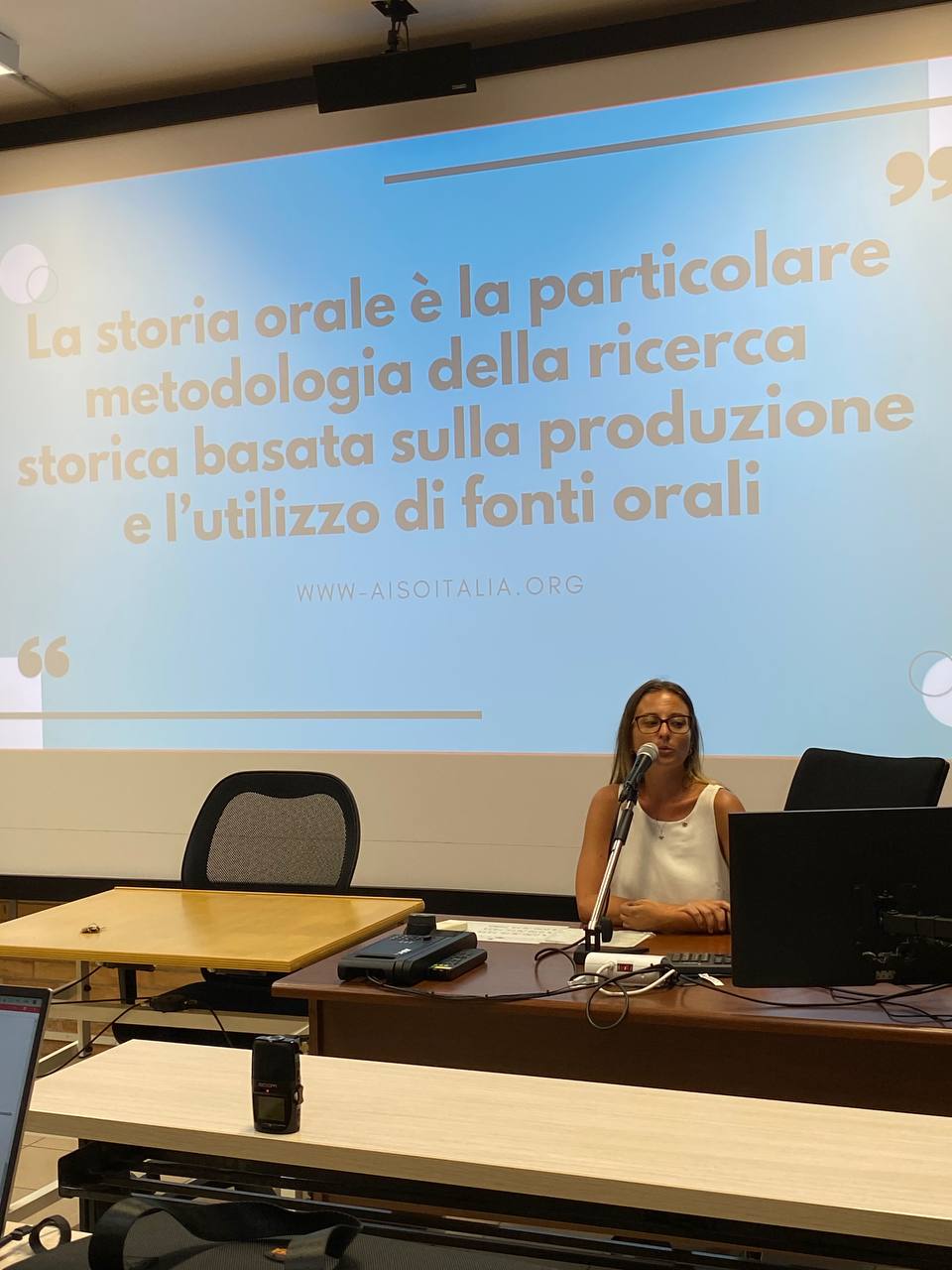di Ivano Peddis
Il quinto incontro della Bottega Digitale è stato dedicato al tema dell’intervista orale, trattato sia dal punto di vista antropologico che dal punto di vista storico.
Un aspetto su cui entrambi i relatori si sono soffermati è quello del consenso al trattamento dei dati, che nella pratica si traduce nello spiegare dettagliatamente in che modo useremo il materiale audio (e talvolta video) che andremo a produrre, e registrare esplicitamente il consenso che viene fornito, in forma verbale o in forma scritta, prima dell’inizio dall’intervista vera e propria. Durante il campo, ci verrà fornito un modello di liberatoria da utilizzare con i nostri testimoni.
Il professor Marco Lutzu, etnomusicologo, ci ha illustrato in cosa consiste un’intervista con le sue diverse tipologie, e ci ha spiegato come si conduce, nella teoria e nella pratica. L’intervista serve a comprendere la realtà sociale a partire dal punto di vista della persona intervistata. Per questo è fondamentale che chi intervista sospenda il proprio giudizio personale su ciò che gli viene raccontato.
Si possono distinguere diverse tipologie di intervista, più o meno strutturata, ognuna coi suoi pro e i suoi contro, da valutare sempre in base al contesto e allo scopo. La scelta delle domande è un altro aspetto su cui porre particolare cura: devono infatti essere neutre (evitando quindi di suggerire risposte o di riflettere giudizi) e aperte, evitando quelle chiuse, che come risposta avrebbero solo sì o no.
Il prof. Lutzu ha approfondito anche alcuni aspetti tecnici riguardo la produzione audiovisiva, come ad esempio il posizionamento di videocamere e microfoni, l’inquadratura, la luce, la strumentazione.
La professoressa Laura Longo ci ha fornito un’introduzione alla metodologia della storia orale.
Innanzitutto ci ha presentato l’associazione di cui fa parte, l’AISO (Associazione Italiana di Storia Orale), che da ben tre anni collabora con il LUDiCa. L’AISO, fondata a Roma nel 2006, raccoglie persone esperte provenienti da varie discipline, con una folta presenza di docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Ma che cos’è esattamente la “storia orale”? Questa è la definizione che ci fornisce l’AISO sul proprio sito internet:
La storia orale è la particolare metodologia della ricerca storica basata sulla produzione e l’utilizzo di fonti orali.
Si tratta di una disciplina nata fuori dalle istituzioni universitarie. Nasce negli USA dopo la Seconda Guerra Mondiale, impiegata per ricostruire la storia di piccole aziende. Dopodiché si sviluppa in seno alle contestazioni sociali del ‘68, utilizzata per indagare, attraverso il metodo dell’intervista, le lotte per i diritti civili, per i diritti di chi lavora e i movimenti femministi. Si trattava di dare voce alle soggettività fino ad allora marginalizzate.
Quando si parla di “fonte orale” si intende che la fonte è il dialogo, che viene registrato (in formato audio o audio e video) e trascritto perché se ne tenga traccia, ma il supporto non è la fonte! Lo stesso atto di trascrizione di un’intervista rappresenta una forma di manomissione, per quanto motivata da esigenze editoriali o di altro tipo. Non a caso, sempre più spesso i girati vengono pubblicati su portali web o su supporti di memoria (CD, DVD) allegati a libri. Ma storia orale è anche la consultazione di fonti orali preesistenti.
Tre sono i concetti chiave su cui si è soffermata la prof.ssa Longo:
- Le fonti sono relazionali, cioè nascono dall’incontro, dal dialogo, sono co-costruite tra chi partecipa a questo dialogo. Sono situate in quel determinato contesto spaziale e temporale e ne sono contaminate.
- Diversamente da chi porta avanti un’inchiesta giornalistica, chi indaga attraverso la storia orale non è alla ricerca de “La verità”, bensì del senso soggettivo, della percezione che la persona intervistata ha dei fatti.
- La memoria non è vista come un deposito passivo, ma come un processo in continuo mutamento.
In collegamento con ciò che ci aveva spiegato prima il prof. Lutzu, la prof.ssa Longo ci ha fornito alcuni consigli pratici sulla realizzazione dell’intervista.
Innanzitutto è importante elaborare un canovaccio, magari con alcuni temi che vogliamo approfondire e delle domande guida (neutre!). Non si può improvvisare!
Dobbiamo mettere la persona intervistata più possibile a suo agio ed essere flessibili, sia con gli orari che col tempo a disposizione che con il luogo.
Come ogni fonte, anche quella orale va schedata attentamente attraverso i metadati per poter essere utilizzata. Alcuni di questi metadati sono il luogo e il tempo in cui si svolge l’intervista, la strumentazione audio (e video) utilizzata, la trascrizione, una breve sintesi, i nomi e i contatti di chi compare, la liberatoria. Evidentemente, maggiori dettagli nella metadatazione equivalgono a un uso più agevole anche da parte di altri progetti di ricerca. Oggi è molto più semplice effettuare le trascrizioni grazie a software avanzati come Transkriptor, sempre con la successiva revisione umana.
Infine la prof.ssa Longo ci ha indicato alcuni documenti per approfondire il tema della storia orale:
Buone pratiche per la storia orale